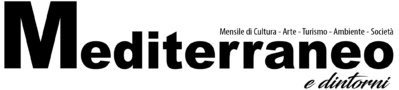di Eliana Iorfrida
Se chiedessimo al prof. Vladimir Nabokov cosa pensa del collega Dostoevskij la risposta sarebbe la seguente:
“Scrittore mediocre, con lampi di humor eccellente ma inframezzato da desolate distese di banalità letterarie”.
(V. Nabokov, Lezioni di letteratura russa, 1981).
Ma come, professore? Davvero sostiene che i poveri personaggi dostoevskiani soffrono tutti, con monotonia, di complessi prefreudiani, limitandosi a sguazzare nelle loro tragiche disavventure senza risoluzione?
Nell’anno delle celebrazioni per l’atteso bicentenario, proviamo a saggiare la misura di un giudizio così tranchant osservando da vicino “il più occidentale dei russi”, Fëdor Dostoevskij, nei panni del suo alter ego, Aleksej Ivanovic, protagonista de Il giocatore (1866) e di un’ossessione che travalica il semplice azzardo per farsi portatrice di un’inquietudine più profonda. Inadeguatezza al vivere, dramma dei drammi.

Un’opera nella quale ogni cosa – “come da copione”, direbbe Nabokov – corre irreparabilmente e a grandi passi verso un disastro annunciato.
La vicenda si svolge malevola, a tratti irritante. I personaggi sono degli inetti patentati, incluso il controverso protagonista, che scientemente esercita l’arte sublime, tutta dostoevskiana, di compiere la scelta sbagliata al momento giusto.
Già! Perché il nostro Aleksej/Fëdor, divorato dall’insana passione per Polina oltre che da quella per il gioco, si lascia sedurre dai propri demòni (sempre loro!), che, puntualmente, lo trascinano in un’inesorabile discesa agli inferi (al sottosuolo). Nel mondo magmatico del casinò di “Roulettenburg”, capace di scaraventarlo dritto verso il fallimento, esattamente come una roulette truccata scaglia la pallina bianca il più lontano possibile dall’anelato e “grandioso 47 rosso”.
Il casinò è osservatorio interessante sull’antropologia malata del Vecchio Continente. È qui che il gioco d’azzardo si declina in tutte le sue forme; è qui che l’umanità degli incalliti sfila in tutta la sua variegata trivialità: nobildonne e nobiluomini decaduti e arricchiti, poveri cristi che si giocano il tutto per tutto, ladruncoli e bari.
“Ci sono due modi di giocare: uno da gentleman, l’altro invece plebeo, venale, insomma il modo di giocare di una canaglia qualsiasi”.
Nei salotti del vizio si lasciano vicendevolmente corrompere quei “tipi” già così bene incasellati nel bestiario di fine Ottocento: l’altezzoso barone tedesco, il francese manipolatore, il ricco gentiluomo inglese e il polacco politicamente scorretto.
Non è forse vero, dice Aleksej/Fëdor, che:
“Dappertutto gli uomini non fanno altro che togliersi o vincersi qualcosa a vicenda”.
Tutti parte di una “narrazione scherzosa”, come la definisce Natalia Ginzburg, non fosse altro che, alla fine, non esiste alcuna possibilità di redenzione. Nessuna crescita, nessuna evoluzione – ci sembra quasi di sentirlo, Nabokov, dall’alto della sua cattedra di Letteratura russa, tuonare “ve lo avevo detto!” – solo la rassegnazione dei disillusi, coloro che accettano le regole del gioco senza, ca va sans dire, nessuna morale.

Che “la bellezza salverà il mondo” resta una grama utopia.
Ivanovic potrebbe salvarsi, è capace di distinguere il Bene dal Male, eppure imbocca consapevolmente la strada sbagliata. Procede lungo un personale cammino di autodistruzione, poiché, in fondo:
“C’è una voluttà nell’estremo grado dell’umiliazione e dell’avvilimento”.