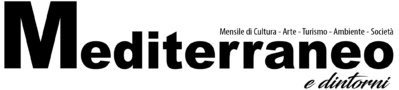*di Federico Quaranta*
Ricordo di aver compiuto tempo fa un lungo cammino in terra d’Abruzzo, un cammino faticoso che dalla Costa Adriatica mi aveva spinto fino al cuore e alla cima della montagna madre: la Maiella. Il viaggio lo ricordo, oggi che in Abruzzo sono tornato a distanza di tempo, accolto in questo Borgo alle pendici del Massiccio, e la sensazione che ora la memoria mi restituisce non è più di fatica, ma di pienezza.
Questo tratto di Adriatico è ben diverso da quello che è presente nell’immaginario collettivo tipicamente romagnolo: placido e calmo. Qui il mare è gonfiato dai venti Grecale e Tramontana, si fa impetuoso e sprofonda nell’abisso a pochi metri dalla spiaggia. Ha costretto gli uomini a ingegnarsi per creare un rapporto intenso con lui: è la Costa dei Trabocchi quella che va da Vasto, a sud, fino a Pescara, a nord. D’Annunzio veniva spesso qui ad ammirare le macchine da pesca, le chiamava “ragni colossali” e di loro ha scritto: “per gli scogli perigliosamente ma difettosamente si protendono respirando l’odore delle Alpi”.
Il rapporto di D’Annunzio con la sua terra fu particolarmente travagliato, odio e amore, distacchi e ritorni, ne scrisse molto nelle sue opere ma in più di un’occasione la regione assume esclusivamente l’aspetto di scenografia, probabilmente gli andava stretta, per uno come lui, il Vate, che aveva visioni grandi ed illuminate. Ma una cosa è certa: sono stati i suoi paesaggi a creargli un immaginario, il mare impetuoso e la montagna sacra a tutti gli abruzzesi che egli chiamava “madre”: la Maiella.

Sulla Costa dei Trabocchi e in questa casa completamente isolata tra il 22 di luglio ed il 23 settembre del 1889 si ritirò, in compagnia della sua amante, la bella romana, Gabriele D’Annunzio proprio per sfuggire a tutti quei pettegolezzi che si stavano diffondendo nella capitale. Gabriele D’Annunzio era sposato, anche Barbara Leoni viveva un matrimonio infelice. Ma nonostante le relazioni coniugali, Gabriele D’Annunzio aveva sempre bisogno di vivere profondi fremiti e passioni travolgenti, le sue amanti rappresentavano per lui delle vere e proprie muse ispiratrici. Qui scrisse, dedicandolo alla bella romana, uno dei più importanti tra i suoi romanzi: Il trionfo della morte. Nel romanzo, così come nella vita reale, i due protagonisti venendo qua incontrarono un Abruzzo che viveva ancora fortemente di ritualità arcaiche e pastorali, con una religiosità scaramantica e superstiziosa capace, potentemente, di sconvolgere la vita di cittadini nobili e borghesi com’erano loro. Un mondo primitivo e primordiale, brutale e festoso che D’Annunzio, per valore intellettuale e ambizione, naturalmente respinge, ma al quale per radici sentiva visceralmente di appartenere e di capire.
Pur avendo trascorso pochi anni della sua vita in Abruzzo, a Pescara, sua città natale, D’Annunzio è sempre rimasto ineludibilmente legato: Le novelle della Pescara, Terra Vergine, le prime sperimentazioni novellistiche in cui D’Annunzio davvero rappresenta e raffigura la gente della sua terra. Quando scriverà i primi romanzi, quando soprattutto scriverà quelle prose memoriali straordinarie al ritorno dall’esilio francese, pensiamo a Il Notturno, Le Faville del maglio, Il libro segreto, l’Abruzzo e Pescara torneranno prorompenti nei suoi ricordi. La casa natale di Corso Manthonè, la Pineta D’Avalos e tutta una serie di ricordi che lo condurranno al pensiero della madre, dei fratelli ed evidentemente di quella famiglia che lui aveva abbandonato molto prima.

Ho camminato a lungo per le campagne di questa terra d’Abruzzo; quelle che d’inverno si fanno gelide, aspre e rigide, lungo i sentieri calcati per millenni dai transumanti con le loro greggi e mi è venuta in mente una poesia dedicata da D’Annunzio proprio i pastori d’Abruzzo: “Andiamo è tempo di migrare, ora in terra d’Abruzzo i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare, vanno verso l’Adriatico selvaggio che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri che sapor d’acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto che lungo illuda la loro sete in via”.
Se c’è un uomo, un poeta in questo caso, che ha veramente dedicato la sua vita ai cani e li ha amati profondamente è D’Annunzio. Lui passava ore ad osservare i suoi cani e diceva addirittura di averne compreso il linguaggio, di aver capito quando i cani dialogavano gli uni con gli altri. Non a caso questa regione ha un legame particolare con il cane, basti pensare al pastore Maremmano, detto anche pastore Abruzzese. Questi cani bianchi sono un po’ il simbolo e l’orgoglio degli abruzzesi e della loro tradizione pastorale. Sono cani antichissimi. Varrone e Clumella parlano di grandi cani bianchi che proteggevano le greggi nelle campagne romane già addirittura nel Primo e Secondo secolo avanti Cristo. E’ un cane forte ed è un cane famoso per la sua indipendenza, vive in totale simbiosi con le pecore senza praticamente mai cercare il contatto con l’uomo, nemmeno col proprio padrone ed è un cane così bravo nel suo lavoro che è stato esportato in tutto il mondo.

“O vita, dono terribile del dio, come una spada fedele, dono dell’Immortale alla mia sete crudele, alla mia fame vorace, alla mia sete e alla mia fame O nacqui ogni mattina. Ogni mio risveglio fu come un’improvvisa nascita nella luce: attoniti i miei occhi miravano la luce e il mondo”. E’ con i versi della Maia d’Annunziana che ho fatto finalmente ingresso nella montagna: la Maiella. E mi è parso di entrare nel ventre materno, e mi è sembrato di nascere nuovamente, una frattura nella roccia ha creato chissà quanti migliaia di anni fa queste gole, che sembrano il corridoio per cui si accede a un mistero, il mistero di una vita resa sacra dalla mano di una dea alla quale chiediamo di farci aprire gli occhi alla meraviglia del Creato.
La Maiella, nel suo ventre, nelle viscere della montagna, i sentimenti che si provano all’interno di questa gola sono molteplici e in contrasto fra loro: da una parte la meraviglia: ci si sente quasi abbracciati, accolti benevolmente da questa natura poderosa. Dall’altra parte la sua forma estetica così dura, così severa, austera crea inquietudine. Le stesse emozioni che vivevano i popoli che per millenni, qui all’interno di questa spaccatura, si sono sentiti profondamente custoditi. E allora deferenza, una sorta di rispetto nei confronti proprio di questa natura che era così inclusiva. Dall’altra parte però anche un timore reverenziale proprio per la magnificenza che su di loro incombeva.
Le Gole di San Martino. La leggenda narra di come sia stato proprio il Santo con la forza dei gomiti ad aprire un varco nella roccia, il suo intento era quello di creare un passaggio per poter giungere nel vallone di Santo Spirito ed erigere una chiesa in suo onore. Al principio, nell’XI secolo, era poco più di un eremo, una piccola cappella votiva. Poi piano piano ampliata fino a diventare un’Abbazia. Nell’Ottocento un imponente alluvione la coprì completamente e i lavori di scavo, da quel momento, sono andati avanti per moltissimi anni e lo si deve alla forza, alla tenacia e alla fede degli abitanti di Fara San Martino se ancora oggi, qui, vengono in processione.
E’ una sensazione molto particolare quella che offre un territorio così amico, che ti dona un senso profondo di partecipazione e appartenenza. E’ come se lo conoscessi da sempre, ma lo visitassi per la prima volta, e mi ricorda quel momento miracoloso e commovente, comune a tutti, in cui diventando grande vedi invecchiare i suoi genitori ed è l’ora di diventarne padre e madre.

A proposito della Maiella si raccontano numerosissime storie e leggende, ma la prima domanda da porsi è il perché gli abruzzesi la considerino realmente una montagna sacra, una vera e propria madre. Tutto è da ricondurre al mito della dea Maia, quella della rinascita primaverile, della fertilità, a cui è stato dedicato il mese di maggio. Bene, lei in fuga dalla Frigia, raggiunge i monti dell’Abruzzo con suo figlio Ermes ferito, in cerca di erbe medicamentose utili proprio alla cura del suo prediletto. Quando viene qui però un’importantissima nevicata copre completamente tutta la montagna, i campi e le vallate. Lei disperata non trova nulla per poter medicare le ferite del figlio e allora, di stenti, Ermes muore. La madre, distrutta, lo seppellisce su queste montagne e con una pazza inizia a girovagare. Chi viene da Levante può ancora scorgere disegnato sul profilo del Gran Sasso proprio l’effigie di Ermes. La madre sconvolta erra per molto tempo fino a che anch’essa per la fame e gli stenti perisce. Viene ritrovata da alcuni pastori che magnanimi nei confronti di una madre così disperata la seppelliscono in mezzo agli anfratti. Ed è per questo che la Maiella porta il nome di Maia. La metafora è quella di una madre impietrita dal dolore. E si racconta che ancora ora quando la tempesta soffia impetuosa lungo i canaloni, si senta un pianto, delle grida: le stesse di Maia distrutta dal dolore.
Tra tutti gli scritti di D’Annunzio, ce n’è uno che tratta della sua terra in modo solo marginale ma profondissimo, ed è Il Notturno. Lo scrive in un momento estremamente delicato della sua vita, aveva appena patito un terribile incidente aereo che l’aveva reso praticamente cieco e costretto all’immobilità, eppure in quel momento egli chiede di poter scrivere. Lo fa su striscette di carta che la figlia ricopia, e proprio in quell’atto e ritrova se stesso. Compie un altro gesto eroico: indaga nel suo profondo e che cosa scopre? Il rapporto con la sua terra e con sua madre, e spesso le due cose coincidono. Egli a questo proposito scrive: “Dappertutto tu sei, come l’aria e l’acqua. Fai buona ogni cosa, fai semplice ogni cosa, il paese, me, come un’iniziazione la tua bontà. Io guardo verso le montagne dove forse un’altra greggia s’abbevera alle sorgenti solitarie e un rammarico lungo mi punge, di non ritornare a te con i miei piedi scalzi, fratello di quel pellegrino che va verso il santuario dei miracoli”.
Ed è attraversando la Maiella, la montagna madre, che ho pensato proprio a questo brano e allora ho voluto raggiungere anch’io un santuario, non so se dei miracoli, ma miracolosa è stata la sua visione.
“Custodisci il silenzio e il silenzio custodirà te”. E’ un Ode basiliana al nome stesso del sentiero che esiste a 1300 metri di altitudine, nel cuore della Maiella, che domina l’intero territorio e si riflette sul mar Adriatico, luogo da dove siamo partiti. E in questo ambiente così selvaggio e lussureggiante, privo di rumore e pacificante, c’è da chiedersi come un posto tale, così ideale per la riflessione e la spiritualità, possa accogliere gli esseri umani. Apparentemente sembra ostile, eppure su uno sperone di roccia enorme, ecco un eremo. Qualcuno ha scelto proprio questa foresta come dimora.
E’ il Santuario della Madonna dell’altare, qui tutto è devoto ad una madre, sia Celeste, sia terrena. E tra il 1235 al 1238 fu il primo Eremo di Pietro Angelerio, colui che divenne Papa Celestino V. Era un uomo semplice, un frate, un eremita, poco avvezzo alle questioni politiche e amministrative dello Stato Pontificio. Forse anche per questo il suo pontificato durò appena quattro mesi. La sua vocazione lo portava a preferire una vita ritirata fatta di raccoglimento, contemplazione e preghiera. Non conosceva bene il latino, preferiva utilizzare la lingua volgare facendosi aiutare dai propri Vescovi, i quali lo avevano eletto probabilmente con l’intento di poterlo manipolare. Si dice che il suo successore, Bonifacio VIII, da prima lo abbia aiutato a rinunciare all’ufficio di Romano Pontefice e poi lo abbia fatto catturare e rinchiudere. Morì di fame e stenti dopo aver celebrato la sua ultima messa.

IL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
Il Parco Nazionale della Maiella ospita una grande varietà di fauna selvatica, l’ampissima copertura forestale, le montagne, a tratti inaccessibili, sono il luogo ideale per gli animali non domestici. Questa è una terra che non solo è nota per la presenza del lupo, simbolo del parco, ma anche per un altro predatore: l’orso. Non un orso a caso però. Si tratta dell’Orso bruno Marsicano, è uno degli animali, degli orsi, più rari e minacciati di estinzione al mondo, tanto che ne sopravvivono poche decine. E’ diverso geneticamente dal resto degli orsi d’Europa, e quindi è una peculiarità tutta italiana. Ernest Hemingway diceva che sparare ad un orso era come sparare ad un fratello e probabilmente gli abruzzesi hanno preso coscienza di questa realtà, di questa verità profonda, perché qui sopravvivono letteralmente gli ultimi orsi dell’Appennino.
Sì, camminai davvero molto e le gambe pesavano come macigni, passo dopo passo, ma quando mi approssimai al Blockhaus, una delle cime della Maiella, nonostante il vento e la neve mi tagliassero la pelle del viso, mi parve di non sentirla più la fatica. Il mio viaggio stava per giungere al termine. “Da questa balza che s’eleva ardita ti guardo, o Sannio mio”, scriveva D’Annunzio in una poesia che dedica alla sua terra e continuava “…in cor mio sento rifiorir la vita con ardente disìo”. E aveva ragione D’Annunzio, salire sulla Maiella è come tornare là dove tutto è cominciato, però con gli occhi di chi è venuto al mondo per la prima volta. Tornare sulla Maiella è come rinascere.