
*di Carlo Piano*
C’è un piccolo borgo (pardon, un principato) incastonato nel verde smagliante delle colline dell’estremo ponente ligure e affacciato su un mare così blu che in lontananza sembra dipinto. Lungo i carrugi e nelle piazzette medievali le bandiere biancocelesti del regno garriscono al ponentino che spira dalla Costa Azzurra. Si chiama Seborga e lotta da mezzo secolo per riacquistare l’indipendenza dall’Italia.

La natura qui è stata generosa: il clima è mite d’inverno e fresco d’estate, si è abbastanza vicini al Mediterraneo per respirarne lo iodio e prudentemente lontani da sottrarsi agli schiamazzi dei vacanzieri. Siamo sulla sommità di un promontorio dal crinale boscoso che dai monti Bignone e Caggio declina a terrazze disseminate di ulivi verso la costa. Intorno ginestre, mimose e fiori d’ogni sfumatura coronano le alture inebriando l’aria di profumi.
Tocca in questo frangente alla principessa Nina I (al secolo Nina Dobler Menegatto) condurre la pugna per liberare Seborga dal «giogo italiano», come sancito da un plebiscito tra i suoi trecento abitanti.
Un’indipendenza de jure, secondo la sovrana, che è rimasta impigliata tra le pieghe dei trattati e della storia. La faccenda è così riassunta: Seborga divenne uno stato indipendente già nel 954, con la donazione del Conte Guidone di Ventimiglia ai monaci benedettini dell’Abbazia di Lerino, e nel 1079 si trasformò in principato. Nel 1729 il principato venne venduto dai religiosi a Vittorio Amedeo II di Savoia, ma le pattuite 147.000 lire sabaude non furono mai pagate e di conseguenza l’atto mai registrato. Infatti, nessun documento del Congresso di Vienna riporta lo staterello ligure come parte del Regno di Sardegna: ne conseguirebbe che l’annessione, nel 1861, al Regno d’Italia e, nel 1946, all’attuale Repubblica è «da considerarsi unilaterale e illegittima». Naturalmente a Roma sono di parere contrario, tanto che la Corte costituzionale ha respinto come «inammissibili» le rivendicazioni autonomiste dei seborghini. Che non si danno per vinti, anche perché nella loro costituzione è scritto chiaro: coloro che non lottano per la sovranità «sono da considerarsi indegni di calpestare il suolo che Dio e la storia hanno ad essi concesso». In altre parole, sono dei traditori. Si stanno preparando nuovi ricorsi alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo e al Tribunale dell’Aja.

Sarà la volta buona? Pare non nutrire dubbi la principessa Nina che cita – nientepopodimeno – che Margaret Thatcher: «Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna». Nell’attesa di svincolarsi dall’Italia si continua a battere moneta, come al tempo dei benedettini, nell’antica zecca del Palazzo dei Monaci: qui viene coniato il luigino il cui valore corrisponderebbe alla Borsa di New York (in base a un incomprensibile calcolo) a sei dollari. La moneta è spendibile in tutti gli esercizi del paese. La Corona ha anche creato una polizia in divisa battezzata Guardia nazionale e piazzato garitte sul confine comunale con la limitrofa Vallebona, che ancora si domanda a cosa servano. Poi ci sono i passaporti, i francobolli, le targhe automobilistiche a corredo di quelle italiane, la nazionale di calcio affidata a un allenatore-giocatore. Perché i fondi non sono quelli della Juventus. Sono stati aperti uffici di rappresentanza all’estero: Stati Uniti, Argentina, India, Costa d’Avorio, Germania…

Non manca l’inno nazionale che s’intitola La Speranza: «E vai, sii uomo e vai, di bianco e azzurro vestiti! E vai, seborghino vai. Non ti fermare mai se trovi degli ostacoli». Questo minuscolo regno vanta anche il suo gossip, quasi a echeggiare le vicissitudini che tormentano la vicina Montecarlo con la crisi tra il principe Alberto di Monaco e la consorte Charlène.
Nina, infatti, è l’ex moglie del principe Marcello I costretto ad abdicare dal trono dopo essere stato «paparazzato» in affettuosa compagnia della stilista di borse di lusso Sofia al Asfoor. Per la principessa quello del marito fedifrago è però un capitolo chiuso: «Parliamo piuttosto di tre ottimi motivi per visitare Seborga – spiega sua altezza, occhi cerulei e chioma dorata – il primo è la storia: siamo l’unico esempio di un principato cistercense e i nostri gioielli artistici lo testimoniano. Il secondo è la natura: siamo la capitale mondiale della mimosa e il panorama è mozzafiato. Da qui si possono vedere quattro stati: Seborga stessa, l’Italia e, aldilà delle Alpi, la Francia e il Principato di Monaco. Terzo motivo è la tranquillità: siamo un paese piccolo ma accogliente e sicuro, dove la pandemia ha colpito lievemente e dove si seguono le regole». In campo gastronomico orgoglio nazionale è il coniglio alla seborghina, cucinato con olive e pinoli e servito in una terrina di terracotta. Da innaffiarsi preferibilmente con Rossese di Dolceacqua.

I gonfaloni sventolano sulle torri e sulle tre porte che difendevano dall’invasore: Porta San Martino, Porta di San Sebastiano e la Porta del Sole. Lo stemma campeggia sul sagrato in pietra della chiesa parrocchiale barocca, costruita nel XVII secolo dall’architetto genovese Arturo Fieschi e intitolata a San Martino di Tours. Che sia suolo italiano o meno questo borgo è stato inserito tra i cento più belli del Paese: «Siamo indipendenti perché non abbiamo mai smesso di esserlo, nulla è impossibile guardate cosa è successo con la Brexit», sono le ultime parole di una principessa che lo scettro non molla.
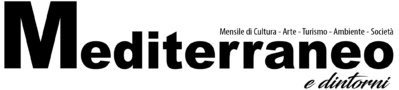













Bellissima storia.