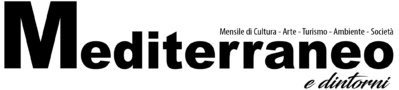di Roberto Balzani – professore ordinario di Storia contemporanea Università di Bologna
La presa di Roma, con la storica breccia aperta nelle mura all’altezza di Porta Pia, il 20 settembre 1870, era un tempo un data fra le più note della nazione. Carducci, ad esempio, aveva addirittura proposto, sul finire dell’Ottocento, di abolire la festa nazionale dello Statuto (la Costituzione concessa da re Carlo Alberto nel 1848), che cadeva la prima domenica di giugno, per sostituirla con il giorno in cui il Risorgimento era virtualmente finito. Non se ne fece nulla, ma nei decenni successivi la ricorrenza della breve campagna militare – la prima “fortunata” del nuovo Stato – restò fra le date memorabili. Vennero poi i Patti Lateranensi e, nel 1929, l’appannamento dell’idea laica del Regno d’Italia che aveva accompagnato l’età liberale: la breccia che aveva sigillato il potere temporale di Pio IX passò di moda. Nell’età repubblicana, anche il centenario, pur celebrato da convegni storici, trascorse un po’ in sordina, in un’Italia che aveva ben altri problemi: tutto il Risorgimento, all’epoca, era un po’ démodé, travolto dalla contestazione dei luoghi comuni, dei simboli e delle idee di fondo ereditate da una formazione vecchio stile ancora marcata dal nazionalismo.
Il 20 settembre 1870, grazie alla sconfitta della Francia di Napoleone III ad opera dell’alleanza tedesca guidata dalla Prussia, si era consumato un evento inatteso: la garanzia militare storicamente assicurata da Parigi al Papa-Re aveva cessato di essere esigibile, e lo Stato pontificio si era ritrovato sostanzialmente indifeso, con un esercito ridotto e un piccolo corpo di volontari assai motivati, ma senza una guida altrettanto determinata. Presso la corte di Roma era noto che un bagno di sangue doveva essere evitato: la “crociata” contro gli italiani poteva essere evocata ma non combattuta, se non simbolicamente. Pio IX, attraverso la convocazione di un grande Concilio ecumenico, era preoccupato piuttosto, in quel momento, di compattare i fedeli intorno alla figura del Santo Padre, il cui ruolo, sotto il profilo dottrinale, era uscito rafforzato; la questione militare passava evidentemente in secondo piano. La presa di distanze dalla vita politica della penisola, del resto, era già stata enfatizzata dal non expedit (1868), che proibiva ai cattolici di partecipare alle elezioni.
Per l’esercito italiano, invece, uscito da una prova disastrosa, la guerra del 1866 contro l’Austria, conclusasi con la duplice sconfitta di Custoza e di Lissa e con una vittoria “a tavolino” ottenuta solo grazie ai successi dell’alleato prussiano, si trattava di dar prova come minimo di efficienza. Il che accadde, per la verità: i reparti manovrarono con precisione, ma il nemico era davvero poca cosa. Sul campo, gli aggressori erano fra i 40 e i 50.000; i difensori circa 10.000. Il generale Raffaele Cadorna, posto alla guida delle truppe regie, stilò il 26 settembre un rapporto nel quale si registravano 38 morti e 150 feriti, un terzo dei quali bersaglieri; i pontifici avevano lasciato sul campo 16 morti e 58 feriti, la maggior parte dei quali appartenenti ai volontari stranieri.
Non una guerra vera e propria, quindi; in fondo, l’unico vero scontro era stato quello intorno a Porta Pia, con l’assalto dei bersaglieri contrastato da pontifici dotati di ottimi fucili a retrocarica. I numeri, tuttavia, non lasciavano spazio a dubbi di sorta sull’esito finale; né d’altronde, presso la corte di Roma, c’era intenzione di andare oltre. Pio IX, con la legge cosiddetta delle Guarentigie, approvata l’anno successivo, manteneva il controllo dei palazzi vaticani e godeva delle libertà tipiche di un sovrano, ma non aveva territorio: il potere temporale, l’incubo dei patrioti del Risorgimento, era stato cancellato. La società italiana, già fratturata dalla questione nazionale, sarebbe stata attraversata a lungo dal confronto fra Stato e Chiesa, con un’opposizione cattolica durissima almeno fino allo scadere del secolo. Nel Novecento le cose sarebbero cambiate: la partecipazione alle elezioni, le seduzioni del nazionalismo, l’affacciarsi di una generazione nuova, non dipendente dalle inimicizie del ’48, finirono per influire sull’antica “questione romana”, attenuando le contrapposizioni: la Grande Guerra avrebbe funto da magnete collettivo, da fortissimo integratore dei diversi modi di essere italiani. Dopo, nulla sarebbe stato più come prima del 1915. Edmondo De Amicis, uno dei più famosi e popolari narratori dell’epopea nazionale in epoca umbertina, sarebbe parso allora come un personaggio da libro di scuola. Eppure, ai suoi tempi, la breccia di Porta Pia era stata davvero un passaggio decisivo del “fare la nazione”: «Molti dei soldati – aveva scritto – nei loro villaggi e nelle loro campagne, dall’ultimo abituro delle Alpi all’ultimo della Sicilia, insegneranno ai loro fanciulli il nome di Roma come vennero insegnati a loro i colori della bandiera e il nome del Re. E Roma sarà pei loro figli il primo degli affetti, dopo quello della Patria e della libertà».
La presa di Roma coronava dunque la stagione dell’indipendenza: lo stesso Cavour, nel 1861, aveva tenuto uno dei suoi ultimi discorsi proprio dedicandolo alla “tappa” successiva, immancabile, della Città Eterna. A Roma non era riuscito ad arrivare Garibaldi, fermato a Mentana dai francesi nel novembre 1867 e, nel settembre del 1870, relegato alla sua Caprera. Né vi era riuscito Mazzini, in quel momento in prigione a Gaeta per evitare che si creassero disordini: il successo dell’operazione Porta Pia era tutto della monarchia, del pater patriae Vittorio Emanuele. Ciò, forse, contribuisce a spiegare, al di là della conquista della Capitale, il motivo per cui il XX settembre sarebbe divenuta una memoria in qualche modo “scomoda”, già attenuata durante il fascismo. Dopo il referendum del 2 giugno 1946, altri momenti del Risorgimento sarebbero parsi più memorabili; e così, sulla fatidica breccia, tanto celebrata nell’Italia liberale, cadde lentamente il velo dell’oblio.